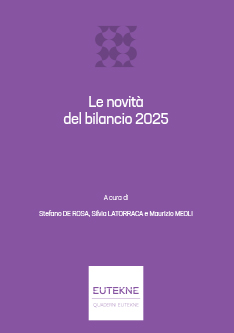Oriente e Occidente, le cause della crisi di cui nessuno parla
Alle radici dell’attuale contesto, una politica economica e doganale sbilanciata sul fronte degli obblighi da rispettare a livello globale
Pubblichiamo l’intervento di Roberto Baggio, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.
Per capire la fase storica attuale, è necessario non confondere gli effetti con le cause della crisi ed essere coscienti che quella odierna non è una crisi globale, ma una crisi dei Paesi occidentali. Le vere cause vanno innanzitutto ricercate nella mediocrità delle classi dirigenti che hanno guidato questi Paesi nell’ultimo quarto di secolo. E non si tratta solo della classe politica, ma di tutti coloro che hanno avuto (e hanno) un ruolo di primo piano nella determinazione e nella gestione delle politiche economiche, sociali, imprenditoriali e monetarie degli Stati.
L’incapacità di sottrarsi alle pressioni dei grandi potentati economici e finanziari ha determinato l’apertura incondizionata e repentina dei mercati occidentali alle produzioni di massa dei Paesi asiatici, dove le grandi multinazionali, per prime, a cominciare dalla metà degli anni Novanta, avevano investito massicciamente nella realizzazione di impianti produttivi. Per realizzare gli auspicati incrementi di margini e profitti, però, occorreva abbattere le restrizioni quantitative sulle importazioni da quelle aree e le tariffe daziarie.
E questi scellerati obiettivi sono stati raggiunti in pochi anni, con la complicità delle classi dirigenti sopra menzionate. Dopodiché è stato inevitabile che anche le altre imprese delocalizzassero per evitare di soccombere. Ne è seguita la grande moria delle aziende tipiche del tessuto imprenditoriale italiano, colpendo prima i settori delle scarpe e dell’abbigliamento e poi, via via, molti altri. E tutto ciò senza che nessuno preavvertisse gli interessati e l’intero Paese di questi inevitabili effetti. La classe politica italiana più di quella degli altri Paesi va messa sotto accusa per un motivo: essa storicamente non ha riguardo all’interesse nazionale. Questo fatto ha reso il nostro Paese il primo (ma non certo l’ultimo), tra i Paesi occidentali, a subire la crisi industriale e a subirne gli effetti negativi maggiori. Quanti sanno, ad esempio, qual è il dazio sulle camicie importate dall’India? 12%. Quanto quello sui mobili provenienti dalla Cina? 5,6%. E quello sulle montature di occhiali importati dai Paesi terzi? 2,2%. E quello sui frigoriferi? 1,9%.
Lo spostamento progressivo di produzioni industriali dall’Occidente all’Oriente non poteva non incidere sulla domanda interna e sui consumi nei Paesi occidentali. Per sostenere domanda e consumi, ecco allora che si è data la stura alla finanza facile, con bassi tassi d’interesse, grandi iniezioni di liquidità, spesa pubblica ed erogazioni di finanziamenti senza controlli. I risultati di questo comportamento sono oggi sotto gli occhi di tutti.
Chi per anni ha sostenuto che la crescita dei Paesi asiatici avrebbe generato una parallela crescita dei consumi interni di quei Paesi a favore delle produzioni italiane e, più in generale, occidentali è stato clamorosamente smentito dai dati sugli interscambi. Per quanto riguarda l’Italia, il deficit commerciale verso la sola Cina è stato, nel periodo 2006-2010, complessivamente di 59,3 miliardi di dollari. Il deficit USA verso la Cina è stato, solo nel 2010, di oltre 273 miliardi di dollari. Una seria analisi porta a ritenere che in futuro non vi sarà alcuna sostanziale controtendenza.
I consumi sono sì aumentati nei Paesi asiatici, ma a favore delle produzioni interne e di pochi altri Paesi (Giappone e Germania, con la presenza di quest’ultimo Paese che dovrebbe dirla lunga su chi ha avuto solo benefici dall’improvvida politica doganale comunitaria degli ultimi anni), pochissimo a favore delle tipiche produzioni italiane. Sarebbe bastato guardare alla storia economica e culturale della Cina per prevedere un simile esito, ma pochi osservatori hanno messo in luce gli ingentissimi danni sociali, umanitari e ambientali creati nei Paesi come la Cina a causa di una crescita troppo intensa in un arco temporale molto stretto.
Un’intelligente politica economica e doganale, non insensibile alle giuste istanze solidaristiche, avrebbe dovuto definire un graduale – ma sufficientemente lungo – percorso di apertura alle produzioni dei Paesi terzi. La questione non è tanto quella del differenziale del costo del lavoro, ma quella del rispetto di determinati obblighi a livello globale, come quelli sindacali, ambientali, brevettuali, nonché quelli relativi alla salute pubblica, alla sicurezza sul lavoro e così via. Infatti, se è ingiusto e immorale impedire ai Paesi in cui il costo della manodopera è basso di migliorare i propri livelli di vita producendo beni più competitivi, è altresì ingiusto e foriero di giganteschi conflitti sociali soffocare le imprese dei Paesi occidentali con costosi ed innumerevoli adempimenti ed obblighi a livello normativo, salvo poi permettere l’invasione indiscriminata dei prodotti esteri realizzati senza l’osservanza di alcuno o della grande maggioranza di quegli obblighi.
In questo modo, non c’è partita. Il giocatore che deve rispettare molte regole è destinato a soccombere all’altro giocatore, per il quale non esistono regole. Ed è proprio quello che sta succedendo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941