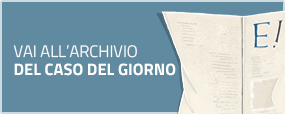Con l’art. 8 del DLgs. 186/2025 (DLgs. in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA), è stata estesa la non imponibilità reddituale delle sopravvenienze attive da esdebitamento agli istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa. In particolare, con una norma di interpretazione autentica dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR, viene sancito che non si considerano sopravvenienze attive:
- in regime di non imponibilità integrale, le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- in regime di non imponibilità parziale, le riduzioni dei debiti nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di un piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. L’intervento, in materia di imposte sui redditi, non è stato accompagnato da una revisione delle disposizioni in ambito IVA, sul fronte dei creditori delle imprese che hanno aderito ai citati istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa (DLgs. 14/2019). La disciplina che consente l’emissione delle note di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3-bis lett. a) del DPR 633/72, non tiene conto delle procedure introdotte con il citato DLgs. 14/2019, né di quelle dettate per il sovraindebitamento (ante e post CCII). L’emissione della nota di variazione è, infatti, espressamente consentita se il debitore è assoggettato a una “procedura concorsuale” e, al riguardo, il comma 10-bis dell’art. 26 fa esclusiva menzione del fallimento (o liquidazione giudiziale, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 349 del DLgs. 14/2019), del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa o dell’amministrazione straordinaria. In questo senso, anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, che commenta le modifiche di cui al DL 73/2021, per le procedure avviate a partire dal 26 maggio 2021 compreso. Inoltre, l’emissione della nota di variazione, da parte del creditore, è possibile nel caso in cui il debitore sia soggetto a un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato oppure a un piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese. Nella disciplina in tema di note di variazione IVA, non è fatta alcuna menzione di ulteriori procedure, introdotte dal DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa o CCII). Tra questi, si annoverano gli istituti di riduzione del debito disciplinati dal nuovo art. 8 del DLgs. 186/2025, per i quali non è prevista la continuità aziendale, ossia: il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 ss. del CCII), il concordato minore liquidatorio (art. 74 ss. del CCII), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del CCII). Con riferimento alla possibilità di emettere la nota di variazione nel concordato semplificato, si è espressa negativamente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 324/2023. In tale sede, è stata esclusa la possibilità di estendere, a livello sistematico, la disciplina prevista per le procedure concorsuali, osservando formalisticamente che l’istituto del concordato semplificato non è menzionato in modo espresso nell’art. 26 commi 3-bis e 10-bis del DPR 633/72. È stata, così, limitata anche la possibilità, per gli operatori del diritto, di estendere in via interpretativa l’ambito applicativo della disciplina IVA ad altre fattispecie, assimilabili solo per l’analoga finalità di risanamento o liquidatoria, scontrandosi con la tesi erariale. [CATENACCIO] Tra gli ulteriori istituti del DLgs. 14/2019 che non trovano diretto riscontro nell’art. 26 del DPR 633/72 e che, pertanto, non sono stati considerati ai fini della disciplina che consente l’emissione della note di variazione in diminuzione, si segnalano in particolare:
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis ss. del CCII);
- gli accordi di ristrutturazione diversi da quelli “ordinari” (art. 57 del CCII, essendo il previgente art. 182 del RD 267/42 menzionato nel DPR 633/72), ossia gli accordi a efficacia estesa e agevolati (artt. 60 e 61 del CCII). È, invece, riconosciuta l’emissione della nota di variazione IVA, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72, nel caso in cui il debitore sia assoggettato alla composizione negoziata della crisi, a decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto o degli accordi sottoscritti con i creditori (art. 25-bis comma 5 del CCII). Rimane necessario uniformare la disciplina delle note di variazione per tutte le procedure. In tal senso, si attende l’attuazione della delega fiscale, conferita al Governo con l’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023, mediante cui dovranno essere estese a tutti gli istituti, liquidatori e di risanamento, contemplati dal CCII, le disposizioni in tema di note di variazione di cui all’art. 26 commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis del DPR 633/72.
28 gennaio 2026
/ Emanuele GRECO e Antonio NICOTRA