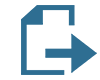Utili al collaboratore dell’impresa familiare in base all’apporto lavorativo
La norma non richiede consequenzialità tra lavoro prestato e incremento dell’azienda ma guarda alla «quantità» e «qualità» delle prestazioni
L’art. 230-bis c.c. racchiude la disciplina dell’impresa familiare, garantendo una specifica tutela ai lavoratori che prestano in modo continuativo la propria opera a favore dell’impresa gestita da un familiare, tutela che si sostanzia nel diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e nella partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Occorre, in primo luogo, ricordare che l’impresa familiare non costituisce una particolare tipologia di impresa, rappresentando tutt’al più un istituto residuale, finalizzato a garantire una tutela minima al collaboratore familiare, evitando a quest’ultimo un ingiusto sfruttamento del lavoro all’interno della comunità familiare; di conseguenza, è bene evidenziarlo, la disciplina in parola trova applicazione in via, appunto, residuale, solamente laddove tra familiari e imprenditore non sia configurabile un’altra tipologia di rapporto, ad esempio, di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.
Da qui, affinché possa dirsi integrata la fattispecie, è necessario che l’apporto del familiare all’impresa si caratterizzi per la continuità: si tratta cioè di un impegno costante del lavoratore, benché non sia richiesto che la prestazione si svolga a tempo pieno (cfr. Cass. n. 27839/2005).
Dalla partecipazione all’impresa familiare, come anticipato, l’art. 230-bis c.c. fa conseguire una serie di diritti, tra cui figura il diritto al mantenimento, ovvero agli utili e agli incrementi dell’impresa. Ed è proprio con riferimento a tale, ultimo, aspetto che la giurisprudenza è più volte tornata e, in particolar modo, sul criterio di determinazione della quota di partecipazione agli utili e agli incrementi spettante al collaboratore.
In merito, va ulteriormente premesso che, come chiarito dalla Cassazione, la ratio dell’art. 230-bis c.c. risiede nel fatto che gli utili e gli incrementi non sono che due diverse modalità di impiego dello stesso risultato economico prodotto attraverso la collaborazione familiare. L’utile infatti rappresenta l’incremento risultante dallo svolgimento dell’attività di impresa nel corso di un esercizio finanziario; gli incrementi patrimoniali derivano dal reinvestimento nell’azienda degli utili conseguiti e non distribuiti (cfr. Cass. n. 27108/2017).
Ebbene, con riferimento al criterio di quantificazione degli utili e degli incrementi spettanti al collaboratore, il punto di partenza è costituito dal dato normativo che, come anticipato, fa riferimento esclusivamente alla “quantità” e alla “qualità” del lavoro prestato. Pertanto, è all’apporto fornito dal collaboratore che bisogna guardare e non, invece, all’incidenza causale sul conseguimento degli utili e degli incrementi, che non rappresentano la misura dell’attività svolta, ma l’effetto; in altre parole, la norma non individua un rapporto di causa-effetto, non richiedendo, cioè, una necessaria consequenzialità tra il lavoro prestato dal collaboratore e l’incremento dell’azienda.
Quindi, come affermato dalla Cassazione con la menzionata pronuncia n. 27108/2017, la liquidazione della quota spettante al collaboratore familiare deve avere quale unico dividendo gli utili, i beni acquistati con essi e gli incrementi e per unico divisore la quantità e la qualità del lavoro prestato (cfr. anche Cass. nn. 32678/2025 e 5224/2016).
Così operando, viene valorizzato il contributo, diretto o indiretto, alla realizzazione di utili e di incrementi dell’impresa apportato dal collaboratore: la partecipazione del collaboratore viene, cioè, letta in funzione dell’apporto di quest’ultimo alla produttività dell’impresa.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941