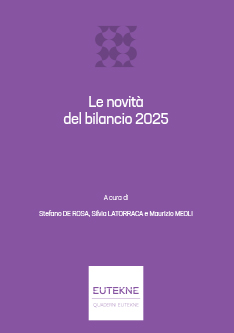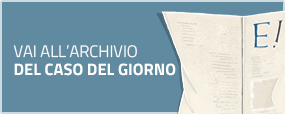Con l’ordinanza n. 14835/2025, la Cassazione ha espresso un principio di diritto intertemporale di particolare rilievo nel contesto non solo delle procedure concorsuali maggiori, ma anche e soprattutto, ai fini che qui interessano, delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, segnatamente, delle procedure di liquidazione del patrimonio e di esdebitazione, rispettivamente disciplinate dagli artt. 14-ter ss. e 14-terdecies della L. 3/2012, ora, pur tacitamente, abrogata dal DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), nella sua attuale versione risultante dalle modifiche apportate dal DLgs. 136/2024, decreto correttivo-ter). Preliminarmente, occorre precisare come la questione posta all’attenzione della Suprema Corte verta, considerato il silenzio sul punto della norma di diritto intertemporale di cui all’art. 390 del CCII, sull’esatta individuazione della disciplina applicabile alle domande di concessione del beneficio dell’esdebitazione proposte dopo il 15 luglio 2022, ovverosia successivamente all’entrata in vigore del CCII, ma da soggetti nei cui confronti sia stata dichiarata l’apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio in base alla disciplina dettata dalla previgente L. 3/2012 (e, segnatamente, dagli artt. 14-ter ss.). I ricorrenti (con soluzione, peraltro, condivisa anche, nelle proprie conclusioni, dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione) ritengono che tale lacuna non possa che implicare l’applicazione dell’art. 389 del CCII, con la conseguenza che la domanda in questione, in quanto depositata dopo l’entrata in vigore del CCII, non potrebbe che essere assoggettata alla nuova disciplina sull’esdebitazione che il Codice della crisi detta (cfr. art. 282 del CCII). La Cassazione, nell’ordinanza in esame, non ha, al contrario, ritenuto di poter condividere la tesi sostenuta dai ricorrenti, né le conclusioni, sviluppate in senso analogo, del Procuratore generale e, pertanto, ha rigettato il ricorso. Ad avviso della Suprema Corta, i debitori assoggettati alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell’esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste dall’art. 14-terdecies della L. 3/2012, dovendosi escludere che le relative domande, semplicemente perché depositate dopo il 15 luglio 2022, siano assoggettate alla norma di cui all’art. 282 del CCII. [CATENACCIO] Secondo l’ordinanza in esame, depongono, in tal senso, due argomenti, uno di carattere sistematico e l’altro di carattere letterale. Con riferimento al primo, la Cassazione osserva che: l’esdebitazione, per come regolata dall’art. 14-terdecies della L. 3/2012, non è un istituto a sé stante, casualmente o, più precisamente, accidentalmente collegato alla procedura di liquidazione del patrimonio in ragione del mero dato temporale, ma attiene, in verità, alla fase conclusiva della procedura liquidatoria, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del sovraindebitato; gli artt. dal 14-ter al 14-terdecies della L. 3/2012 costituiscono un unico corpus normativo e, in particolare, l’art. 14-terdecies della L. 3/2012 integra, a pieno titolo, la complessiva disciplina della liquidazione del patrimonio, tanto da rientrare pienamente nell’efficacia ultrattiva come prevista dall’art. 390 del CCII. Con riferimento al secondo argomento, di carattere letterale, l’ordinanza rileva che, mentre l’art. 14-terdecies della L. 3/2012 riserverebbe chiaramente il beneficio dell’esdebitazione al debitore in stato di sovraindebitamento, gli artt. 278 ss. del CCII, al contrario, riserverebbero detto beneficio esdebitatorio esclusivamente al debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, ovverosia nell’ambito di una procedura concorsuale non pienamente sovrapponibile – e differente sotto diversi aspetti, non soltanto marginali o puramente lessicali, rispetto alla previgente procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012 che qui ci occupa. Considerata la domanda di esdebitazione alla stregua di una “fase” originabile nella o dalla procedura liquidatoria minore, il principio espresso rappresenta un corollario di un principio già espresso in precedenza dalle Sezioni Unite della Cassazione, in forza del quale le norme dettate dal CCII non sono applicabili alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. SS.UU. nn. 12476/2020 e 8504/2021).
21 febbraio 2026
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI