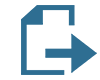La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di impresa familiare
La quota di partecipazione all’incremento di valore aziendale va calcolata in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato
Con l’ordinanza n. 32678/2025, la Cassazione si è pronunciata in materia di impresa familiare, con specifico riferimento ai criteri di determinazione della quota di partecipazione all’incremento del valore aziendale
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941