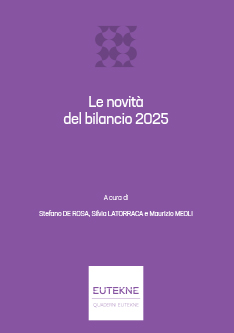Dobbiamo far capire alle imprese l’importanza del controllo di gestione
Gentile Redazione,
l’imminente introduzione delle procedure di allerta descritte nell’art. 4 della L. 155/2017, che ha delegato il Governo a modificare significativamente l’attuale impalcatura della legge fallimentare (risalente al 1942 sia pure rinnovata più volte anche di recente), sarà accompagnata anche da modifiche al codice civile.
Infatti l’articolo 14 del testo della legge delega contiene, alla lettera b), la modifica che prevede “il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Lo scrivente ha avuto modo di esprimersi con una certa cautela (per non dire scetticismo) circa la portata di tale modifica al Codice, di cui si capisce l’intenzione (certamente lodevole), ma di cui è difficile immaginare il coordinamento con le definizioni di natura aziendalistica di crisi e continuità aziendale. E infatti, mentre la crisi troverà la sua definizione proprio nell’ambito della riforma perché a ciò è anche delegato il Governo, la continuità aziendale continuerà a rimanere un presupposto di redazione del bilancio (art. 2423-bis c.c.), la cui valutazione avviene normalmente misurandone i rischi di assenza (principio di revisione ISA Italia 570).
Nelle more della redazione del testo delegato al fine di leggere come il legislatore avrà declinato sul punto specifico i concetti della lett. b) dell’art. 14 della legge delega sopra riportati, si può senz’altro osservare che l’effetto sostanziale di questa modifica sarà il bisogno (non nuovo per la verità!) per ciascuna impresa di dotarsi in maniera strutturata di metodi di rilevazione del mantenimento della continuità aziendale. E tali metodi non possono che essere basati sul controllo di gestione.
Il controllo di gestione implica per l’impresa la capacità di analisi continua della propria attività sia in senso commerciale e industriale, sia in senso finanziario, amministrativo e strutturale. Non solo, quindi, un’analisi (magari frettolosa) a consuntivo, ma anche e soprattutto analisi preventive (budget economici e finanziari) con cui misurare le performance aziendali in un futuro ragionevolmente prossimo da cui trarre conoscenza dei flussi di cassa necessari al sostegno della continuità aziendale.
Per calcolare correttamente i flussi di cassa futuri l’azienda dovrà acquisire la capacità di costruire e mantenere adeguata informativa non solo sulla propria capacità industriale, commerciale e finanziaria, ma anche sulle dinamiche del settore merceologico di riferimento e sui principali competitor.
L’esperienza dimostra che le PMI italiane, caratterizzate da un tessuto composto più da piccole che medie imprese, sono normalmente o poco inclini o poco strutturate sul controllo di gestione.
Rendere sistematico questo vitale esercizio di buona conduzione aziendale è compito della professione del dottore commercialista.
Occorre diffondere la consapevolezza della importanza del controllo di gestione quale strumento ordinario di best practice, strumento che diviene ora parte integrante dei doveri civilistici posti in capo al “buon imprenditore” e che diviene pane quotidiano per ogni organo di controllo.
I benefici derivanti dalla buona esecuzione del controllo di gestione si riverbereranno anche nel migliorato rapporto con il sistema finanziario e ridurranno i rischi di default.
Ciò aiuterà anche la professione nell’esecuzione dell’incarico di controllo legale dei conti ora previsto anche, fra le altre novità, per realtà con volumi di affari superiori a due milioni di euro.
Federico Diomeda
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941