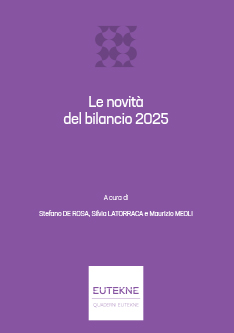Equo compenso per un ritorno alle tariffe professionali
Necessario intervenire per un’adeguata remunerazione delle prestazioni
Pubblichiamo l’intervento di Michela Boidi e Sebastiano Zanette, Consiglieri Giunta UNGDCEC delegati area Studi Professionali, Antiriciclaggio e Privacy.
L’abolizione delle tariffe professionali ha lasciato spazio al DM 140/2012 per fissare i parametri per la liquidazione dei compensi in sede di contenzioso. Gli stessi sono poi stati utilizzati, in assenza di altri strumenti, anche come metro di misura per la valorizzazione delle prestazioni professionali in contesti di mercato libero.
Se i sostenitori della liberalizzazione teorizzavano che la presenza di tariffe professionali fosse lesiva del principio di libera concorrenza, non si può non osservare come la naturale conseguenza di ciò sia stata la creazione di un vero e proprio far west dei compensi, con scandalosi ribassi finalizzati ad attrarre clientela. L’applicazione di compensi particolarmente ridotti, peraltro, non è stata quasi mai accompagnata dall’acquisizione di vantaggi competitivi su cui i professionisti hanno potuto far leva, ma quasi sempre ascrivibile a errate valorizzazioni delle prestazioni, o comunque non in linea con un adeguato riconoscimento della professionalità.
In questo contesto si sono inoltre inseriti prestatori di servizi professionali non ordinistici, in forma individuale o appartenenti alle più varie società di consulenza, che hanno portato avanti una concorrenza sleale, non solo sul tipo di attività, ma ancora di più sui prezzi.
Ciò ha, di fatto, innescato una tendenza sempre più marcata verso l’abbassamento dei compensi, che ha parallelamente portato alla compressione della percezione del valore della professione, permettendo ai clienti di pretendere che determinati servizi venissero offerti a prezzi risibili. Irrimediabilmente, questo ha portato a una contrazione delle marginalità dei professionisti, anche dei più virtuosi, che per rimanere sul mercato hanno spesso dovuto adeguarsi a questo circolo vizioso, anche partecipando a discutibili gare in cui il driver principale era rappresentato dal minor compenso. La conseguenza di tale contrazione si ritrova nella difficoltà di molti professionisti nello strutturare in maniera adeguata i propri studi, che si trovano ad affrontare ogni anno nuovi adempimenti cui difficilmente viene riconosciuto un giusto corrispettivo.
La L. 49/2023 sull’equo compenso si inserisce correttamente in un contesto di maggior tutela delle professioni intellettuali, ma non si possono non rilevare delle zone d’ombra. In prima battuta, la platea dei soggetti a cui la legge si rivolge è limitata, poiché riguarda i rapporti contrattuali tra professionisti e determinate categorie di imprese ed enti pubblici. L’UNGDCEC ha sempre chiesto di estendere tali prescrizioni a tutti e non solo ai soggetti forti, poiché riteniamo che un compenso, quando viene definito equo, lo debba essere in termini assoluti e non solo verso una piccola parte del nostro tessuto economico.
Inoltre, la L. 49/2023 impone di fare riferimento al decreto ministeriale di determinazione dei compensi, ovvero il DM 140/2012. Questo decreto, oltre ad essere superato nelle attività dell’attuale professione, prevede scaglioni privi di un tetto massimo, che in determinati casi portano a compensi sproporzionati. La richiesta di applicare compensi riconosciuti pressoché unanimemente come inapplicabili, e spesso nemmeno ascrivibili a un punto di riferimento a cui tendere, pone il professionista in una posizione di debolezza contrattuale verso la propria controparte e riporta la trattativa a una scelta esclusivamente basata sul prezzo. La revisione di questi parametri è stata richiesta da tutti gli attori della categoria, con l’obiettivo, da un lato, di applicare la L. 49/2023, almeno verso quei soggetti definiti forti, dall’altro lato, di creare un parametro di riferimento per tutti gli altri, potendoli utilizzare in sede di liquidazione giudiziale del compenso.
Oggi, a oltre un anno dall’entrata in vigore della legge, il DM non è stato aggiornato, generando, di fatto, una situazione di inapplicabilità della stessa. Ciò è visibile anche dalle previsioni del codice deontologico, poiché l’art. 25 stabilisce che, nella determinazione del compenso, debba tenersi conto di diversi fattori, tra cui, alla lett. g), i parametri del DM di riferimento, rendendo gli scaglioni proposti solo uno degli elementi da valutare nella pattuizione.
Infine, la conseguenza della mancata applicazione della legge è ora esclusivamente di tipo disciplinare e grava sul solo professionista. Il neo approvato Codice delle sanzioni disciplinari, all’art. 21-bis, prevede infatti l’applicazione della censura.
Sarebbe opportuno, invece, individuare conseguenze sanzionatorie anche per le imprese, altrimenti saranno agevolati i soggetti forti, invece che i professionisti alla cui tutela la legge era finalizzata. Non appare sufficiente la possibilità di invocare la nullità del compenso pattuito, che realisticamente opererà in maniera funzionale solo in situazioni patologiche. Difficilmente il professionista, principale interessato a far valere l’equo compenso, agirà verso la propria controparte, avendo già fatto le proprie valutazioni al momento dell’accettazione dell’incarico.
La modifica del nostro ordinamento professionale rappresenta quindi l’occasione per riaprire il dibattito sul tema e promuovere l’eliminazione di queste storture, permettendo ai professionisti di avere una marginalità che consenta di veder riconosciuta la loro professionalità e che, allo stesso tempo, permetta di strutturare adeguatamente gli studi per rispondere in maniera efficiente alle richieste del mercato.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941