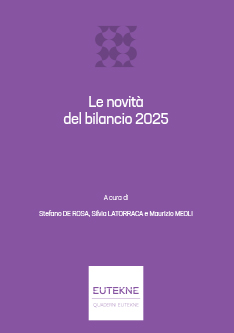La fiscalità dei dividendi italiani ed esteri si divarica
Prime osservazioni sui possibili effetti dell’art. 18 del Ddl. di bilancio 2026, che rischia di creare spazi per arbitraggi
Sono iniziate, con le audizioni preliminari presso le Commissioni Bilancio congiunte del Senato e della Camera e con le prime proposte dei gruppi di interesse, le “manovre” tese a esplicitare le possibili modifiche ...
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941