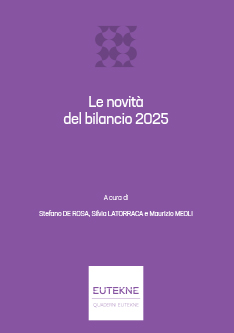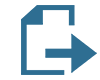Da Eurostat e Istat, dito nella piaga delle contraddizioni italiane
L’Eurostat non avrebbe potuto essere più tempestivo.
I dati diffusi l’altro giorno certificano il basso livello degli stipendi italiani nel settore privato, proprio mentre in Italia si prende atto di come, invece, nel settore pubblico gli stipendi dei dirigenti siano tra i più generosi d’Europa e forse del mondo.
Non è vero, come era sembrato a una prima lettura dei dati, che persino la Spagna e la Grecia ci sopravanzino: l’Istat, nella giornata di ieri, ha con pari tempestività spiegato dove risiedeva l’errata lettura di dati offerti dall’Eurostat in modo evidentemente un po’ criptico.
È però vero che il valore dello stipendio annuo di un lavoratore di un’azienda dell’industria o dei servizi, con almeno dieci dipendenti, si attesta in Italia su livelli inferiori alla media dei sedici Paesi dell’eurozona e su livelli nettamente inferiori a quelli di Paesi come la Francia e la Germania: nel 2008, 29.653 euro contro, rispettivamente, 34.392 euro e 38.005 euro.
Se, nel confronto tra diversi Paesi, alcune (e sottolineiamo alcune) differenze possono trovare parziale (e sottolineiamo parziale) risposta nei diversi livelli di costo della vita che li caratterizzano, nemmeno questa argomentazione può essere sollevata nell’istante in cui si rimane all’interno di un medesimo Paese e, in relazione ad esso, si constata l’esistenza di stipendi del settore privato abbondantemente sotto la media e stipendi per le posizioni apicali del settore pubblico abbondantemente sopra la media.
Quanti sono, nel settore privato di un Paese con livelli remunerativi sotto la media, i manager, i dirigenti e i liberi professionisti che guadagnano più di 300mila euro all’anno e per di più in modo stabile per molti anni consecutivi?
Ha senso che, in un Paese del genere, le cui difficoltà sono peraltro riconducibili proprio alla tenuta dei conti pubblici, dirigenti di Pubbliche Amministrazioni, componenti di authority, direttori di agenzie, amministratori di società interamente partecipate dallo Stato, da Regioni o enti locali e operanti in regime monopolistico di concessione, percepiscano dalla collettività remunerazioni ampiamente superiori, o magari più remunerazioni inferiori a fronte di una pluralità di incarichi che, cumulandosi tra loro, portano al medesimo risultato?
Se tutto questo fosse solo un’ingiustizia sociale, potremmo serenamente indignarci per una o due settimane e poi lasciare tutto come sta. Non possiamo però permettercelo perché, invece, siamo di fronte a una delle ragioni che stanno alla base del processo d’involuzione che sta portando i cittadini di questo Paese a rischiare seriamente di passare dalla dieta alla fame con la stessa velocità con cui, decenni addietro, passarono dalla fame alla dieta.
Un Paese in cui fare carriera nel pubblico impiego o nel parastato è, in termini probabilistici, economicamente più conveniente che fare carriera in un’azienda privata o avviare una propria attività professionale autonoma, è un Paese destinato in partenza al fallimento produttivo e alla corruzione dilagante.
Sarebbe vero anche in un contesto di massima trasparenza amministrativa; figuriamoci in un contesto di opacità spesso imbarazzante.
Servire le istituzioni comporta un riconoscimento sociale che trae le proprie premesse proprio dalla scelta di campo fatta da chi, evidentemente, preferisce impegnarsi nel pubblico, invece che inseguire nel privato guadagni più lucrosi di quelli che, a parità di professionalità, può ottenere da servitore dello Stato.
Abbinare riconoscimento sociale del proprio ruolo pubblico a remunerazioni da settore privato significa gettare le basi per creare un autentico cortocircuito valoriale.
Un tetto di 300mila euro annui per i grand commis di Stato è ben lungi dal rappresentare una mossa viziata da populismo pauperistico, tantopiù in un Paese in cui, nel settore privato, 300mila euro annui rappresentano una somma superiore di oltre dieci volte il livello medio delle remunerazioni.
Chi ritiene che una simile somma non valorizzi adeguatamente la propria professionalità, nemmeno tenendo conto del riconoscimento sociale che, giustamente, si accompagna a certi incarichi svolti nell’interesse della collettività, è libero di andare a guadagnarseli nel settore privato quando meglio crede.
Se stessimo parlando dell’evasione fiscale dei sudditi, la norma sarebbe già in vigore da ieri, senza deroghe e senza bisogno di regolamenti attuativi destinati a perdersi nei meandri dei palazzi.
Il punto è che stiamo parlando degli stipendi dei sovrani.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941