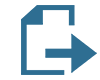Nessun futuro se un Paese si riduce a una caserma di «imboscati»
Si dice spesso che questo Paese è immobile. Magari.
La verità è che siamo in modo conclamato in parabola discendente. Da un punto di vista culturale, prima ancora che da un punto di vista prettamente e grettamente economico.
C’è stata l’epoca della rivendicazione dei diritti per tutti e quella del consolidamento dei diritti per tutti. Epoche sopravvalutate, per carità, perché la storia ha dimostrato che, alla fine, tutte queste conquiste sono state fatte senza vero sacrificio, mettendole in conto alle future generazioni. Eppure epoche in cui le battaglie erano quantomeno giuste e nobili nei presupposti.
Oggi, dopo la rivendicazione e il consolidamento, siamo nell’epoca della difesa dei diritti. Non per tutti, però, questa volta: solo per quelli che li hanno già acquisiti e gli altri chi se ne importa. Ed è qui che sta l’arretramento culturale che rende l’immobilismo addirittura una meta, anziché uno spauracchio.
La cosiddetta seconda Repubblica poteva e doveva essere l’epoca della rimodulazione dei diritti finalizzata a un loro ulteriore consolidamento, nel segno però della loro sostenibilità per tutte le generazioni presenti e pure per le generazioni di domani. Si è invece ridotta ad essere l’epoca della tutela dei diritti acquisiti contro chi quei diritti non solo non li ha, ma nemmeno potrà ambire ad acquisirli in futuro.
Uno degli esempi più tangibili è quello che è accaduto sul mercato del lavoro.
Possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che, oggi come oggi non esistono più per i giovani il bianco della stabilità e il nero dell’autonomia (o viceversa), ma soltanto sfumature del grigio di una precarietà che, per alcuni, è senza partita IVA e per altri con partita IVA?
Possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che la flessibilità è un valore per il datore di lavoro esattamente come la stabilità lo è per il lavoratore e che quindi, come ogni valore, anch’essi debbano avere un prezzo e qualcuno che lo riconosca?
E, se è così, possiamo essere tutti d’accordo che non è possibile avere un mercato del lavoro in cui un rapporto di lavoro flessibile costa meno al datore di lavoro e fa guadagnare meno al lavoratore di un rapporto di lavoro stabile?
Per forza da noi la flessibilità non esiste ed esiste invece la precarietà: se un lavoratore flessibile costa meno, quando mai ci sarà la valutazione costi-benefici tra stabilizzazione del rapporto di lavoro e prosecuzione su base flessibile?
È semplicemente ridicolo.
Nel nostro Paese la flessibilità non è mai stata introdotta: l’unica cosa che è stata introdotta è stato l’abbattimento dei costi del lavoro per imprese e pubbliche amministrazioni a totale carico dei giovani.
Come, sia chiaro, è semplicemente ridicolo chi propone come unica soluzione quella di alzare il costo del lavoro flessibile sopra quello del lavoro stabile, lasciando quest’ultimo invariato. Ecco un bel modo di ragionare da finti amici dei giovani, finti riformatori, finti difensori dei diritti di tutti. Siamo capaci tutti a fare i sindacalisti in questo modo.
Se la flessibilità del rapporto di lavoro è un valore anzitutto per il datore di lavoro, ebbene: ne sopporti il prezzo il datore di lavoro, pagando di più di quello che pagherebbe per quello stesso rapporto di lavoro se fosse stabile.
Al tempo stesso però, se la stabilità di un rapporto di lavoro è un valore anzitutto per il lavoratore, ne sopporti il prezzo il lavoratore, guadagnando di meno di quello che guadagnerebbe per quello stesso rapporto di lavoro se fosse flessibile.
Che è come dire, girando in positivo il ragionamento, che con la stabilità ci guadagna il datore di lavoro e con la flessibilità di guadagna il lavoratore. Ecco un mondo possibile e sostenibile, in cui le alternative esistono per davvero e in cui le scelte sono scelte vere. Certo, ci vuole fegato per riuscire anche solo a immaginarlo e tanto più per provare a spiegarlo a chi ha tutto da perdere da una simile rivoluzione. Prima o poi, però, qualcuno che vuole davvero il bene di questo Paese questo coraggio dovrà pur trovarlo.
Inutile dire poi, a proposito di coraggio, che l’inevitabile ulteriore corollario del ragionamento è che, a parità di mansioni e carichi di lavoro, chi lavora nel pubblico impiego, dove il valore della stabilità è massimo, come l’ultima crisi economica ci ha ricordato, deve essere remunerato meno e non certo di più di chi lavora nel settore privato, altrimenti proseguiamo a costruire un mondo alla rovescia, dove chi sta nelle salmerie è ricoperto di più onori rispetto a chi sta in prima linea.
E intendiamoci: le salmerie sono fondamentali, perché un esercito senza salmerie efficienti perde prima ancora di combattere, ma un esercito in cui tutti vogliono andare nelle salmerie, perché, oltre a stare al caldo anche quando fuori piove, vieni anche considerato di più, finisce col diventare un esercito di imboscati.
Proprio il destino cui sta andando incontro quella grande, decadente caserma, in cui l’unica regola inderogabile è quella del “chi c’è c’è”, che tutti noi ci ostiniamo ancora a chiamare, con affetto e speranza, Italia.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41