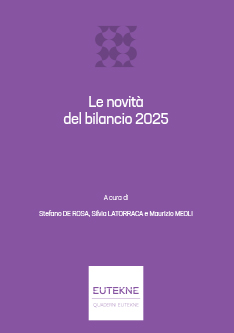Piaccia o non piaccia, hanno ragione i calciatori
Tra le mille polemiche che giustamente accompagnano l’introduzione di un contributo di solidarietà sui cittadini che in dichiarazione espongono un reddito complessivo superiore a 90.000 euro, per di più con effetto retroattivo già per il corrente anno 2011, se ne distingue in particolare una: quella dei calciatori, secondo i quali il contributo dovrà essere a carico delle società.
Una polemica a dir poco surreale, ma non nel senso che intendono i club calcistici e che, con un po’ di pressappochismo populistico, cavalcano alcuni esponenti politici di primo e secondo piano.
Non è una questione categoriale, ma contrattuale.
I calciatori non hanno ovviamente alcun diritto di pretendere di essere trattati, in quanto tali, in modo diverso dagli altri lavoratori dipendenti e parasubordinati, ma hanno tutte le ragioni di questo mondo di pretenderlo se ad essere diversi sono i loro contratti.
Se un contratto, tra un committente (in questo caso le società di calcio) e un prestatore (in questo caso i calciatori), prevede che le parti scelgono liberamente di accordarsi non già per una determinata retribuzione lorda, bensì per un importo netto che deve residuare al prestatore una volta assolti gli oneri tributari, significa che, consapevolmente, quelle medesime parti scelgono di trasformare la variabile fiscale in un elemento che non può incidere finanziariamente sul prestatore e che può invece incidere esclusivamente, in negativo ma anche in positivo, sul costo aziendale per il committente.
Se gli oneri tributari, correlati a una remunerazione basata su pattuizioni contrattuali così concepite, scendessero, il prestatore (calciatore) non avrebbe alcun titolo ad esigere dalla controparte (società) il versamento del minor costo aziendale da essa sopportato, rispetto a quello che sussisteva alla data della stipula del contratto, sulla base delle regole fiscali allora applicabili.
Di converso, se gli oneri tributari salgono, è il committente (società) a non poter pretendere di imporre alla propria controparte (calciatore) una rinegoziazione unilaterale di condizioni contrattuali che dicono tutt’altra cosa rispetto a quello che piacerebbe dicessero.
L’amministratore delegato dell’A.C. Milan, Adriano Galliani, afferma che il contributo di solidarietà è cosa diversa dall’IRPEF e quindi deve intendersi comunque dovuto dal prestatore, sottraendolo al suo “netto in busta”.
Se singoli contratti di calciatori prevedono che l’accordo sulla remunerazione netta è da intendersi come accordo al netto dell’IRPEF, sarà forse possibile dare seguito a quanto affermato da Galliani.
Se però, come è invero più probabile, la generalità dei contratti prevede un generico riferimento a tutti gli oneri tributari gravanti sulle remunerazioni pattuite, le affermazioni di Galliani, dal punto di vista giuridico e contrattuale, lasciano il tempo che trovano.
Ovviamente, nei rapporti tra società e calciatore si dovrebbe poi tenere conto anche dell’effetto finanziario conseguente alla deducibilità per cassa del contributo di solidarietà dall’IRPEF dovuta da quest’ultimo, perché è chiaro che, se il contributo non può tramutassi in uno svantaggio finanziario per il prestatore, ove la pattuizione contrattuale sia sul netto, non può certo nemmeno tramutarsi in un vantaggio.
Nessuno può sapere perché le società calcistiche, con prassi a dir poco inconsueta rispetto a quel che accade nel mondo degli “umani”, abbiano scelto di prediligere accordi sul netto, anziché sul lordo.
Forse si aspettavano una riduzione delle imposte sul reddito sugli scaglioni più elevati, ma è un problema loro.
L’unica certezza è che questa ennesima peculiarità del mondo del calcio, per non dire vera e propria stranezza, non deriva questa volta dal fatto che i calciatori sono speciali rispetto ai comuni mortali, bensì dal fatto che sono speciali i contratti che stipulano con loro quei raffinati strateghi che, nelle società e nelle leghe, dirigono in modo così impeccabile il calcio nostrano.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941