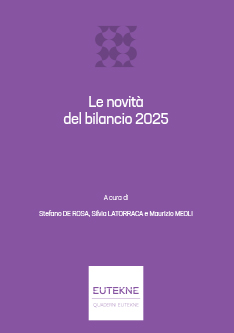Bancarotta fraudolenta, applicabili pene accessorie con concorso materiale di reati
Possibile anche effettuare il sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca ma «sconosciuto» alla bancarotta
Pubblichiamo l’intervento di Vincenzo Pacileo, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino.
Dalla stampa specializzata, si è appreso che nei primi sei mesi del 2013 il danno erariale derivante dalla violazione dell’art. 11 del DLgs. 74/2000 è stato di 435 mln di euro, con un incremento di circa il 30% sull’intero anno precedente. Negli ultimi anni vi è stata una parallela impennata dei fallimenti e delle altre procedure concorsuali. Non che si possa ravvisare un diretto collegamento tra i due dati. Resta, però, il fatto che le manovre frodatorie volte a defraudare l’Erario costituiscono, da una parte, un sintomo di insolvenza (e, almeno parzialmente, anche una concausa) e, dall’altra, consegnano al pubblico ministero uno dei presupposti per la richiesta di fallimento ai sensi dell’art. 7 L. fall. (sotto il profilo del “trafugamento” di beni).
L’alienazione simulata di beni o il compimento di altri atti fraudolenti su di essi integrano il delitto di cui al citato art. 11 quando siano idonei a ostacolare la procedura di riscossione coattiva, a condizione che siano accompagnati dal dolo di evasione. Ebbene, in caso di fallimento (o di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria) quelle stesse condotte integrano ipotesi di bancarotta fraudolenta. Il quesito che ci poniamo, allora, è quale ipotesi precisamente di bancarotta si realizza e se i reati (fiscale e fallimentare) possono materialmente concorrere.
Nessuno dei due interrogativi è puramente accademico perché, come vedremo, dalla soluzione adottata discendono conseguenze pratiche anche molto rilevanti. Quale fattispecie, dunque, di bancarotta fraudolenta?
Vengono subito in mente le “operazioni dolose” di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 L. fall., che si manifestano “in qualunque atto di natura patrimoniale compiuto dall’agente con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, con l’intenzione di conseguire per sé o altri un profitto a danno dei creditori o della società” (Cass. 405/1984).
L’“inconveniente” di questa fattispecie è che essa richiede la prova del nesso causale con il dissesto e che la condotta sia sorretta quanto meno dall’accettazione del rischio di tale evento. Ben più leggero è, invece, l’onere probatorio per il caso di distrazione (se si esclude l’orientamento assolutamente minoritario espresso da Cass. 47502/2012). Orbene, nulla vieta di ricondurre la sottrazione fraudolenta di beni di cui all’art. 11 all’ipotesi “secca” di distrazione fallimentare, che consiste in qualsiasi distacco di beni dal patrimonio con suo ingiustificato depauperamento.
Quanto al quesito se i due reati possano concorrere, esiste uno schieramento che lo nega, condiviso da parte della dottrina, da certa giurisprudenza (Cass. 42156/2011), dalla relazione governativa al DLgs. 74/2000, nonché dalla clausola di salvezza del reato più grave, che compariva come incipit nella originaria formulazione della norma. Esiste, però, anche un orientamento favorevole al concorso materiale di reati, che si va consolidando in giurisprudenza e che è condivisibilmente argomentato sulla diversità degli interessi protetti (tutela dell’Erario e tutela dei creditori in generale), sulla diversa natura del reato (di pericolo e di evento), sul diverso atteggiarsi del dolo (specifico e generico). Si direbbe, poi, che ogni dubbio sia ormai dissipato dalla eliminazione della clausola di riserva ad opera del DL 78/2010.
La ravvisabilità del concorso materiale di reati offre importanti strumenti di contrasto, che la perseguibilità della sola bancarotta fraudolenta non consentirebbe. Innanzitutto, la applicabilità delle pene accessorie di cui all’art. 12 del DLgs. 74/2000. Ma soprattutto la possibilità di effettuare il c.d. sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca (art. 322-ter c.p.), che è previsto per i reati fiscali dall’art. 1, comma 143 della L. 244/2007, ma che è sconosciuto alla bancarotta. Dal momento che assai spesso è difficile individuare la destinazione del profitto del reato (integrato dalla sottrazione del cespite) o, comunque, poterlo aggredire se pervenuto a soggetti in buona fede, diventa di capitale importanza potersi rivolgere ad altri beni di valore equivalente a quelli sottratti.
La sottrazione di beni in danno dell’Erario ai sensi dell’art. 11 citato può manifestarsi anche nella forma della bancarotta preferenziale, allorché alla finalità di frodare il Fisco si accompagni l’intento di favorire altro creditore da parte dell’imprenditore in dissesto. Nel caso in cui il sistema bancario vanti crediti chirografari verso quell’imprenditore e “minacci” la richiesta di rientro, una modalità (illecita) di prosecuzione del rapporto con la banca è quella di ottenere l’accensione di un mutuo ipotecario, la cui provvista serva a ripianare la posizione non garantita. In tale ipotesi, il credito non varia nella sua entità, ma cambia fraudolentemente di natura, al contempo ledendo la par condicio e sottraendo l’immobile alla garanzia dell’Erario.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941