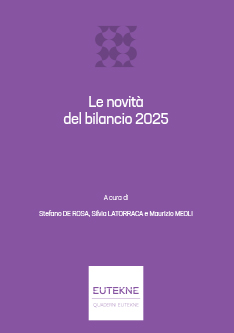Limiti alle indagini della banca sui creditori
La Suprema Corte ha esaminato un caso di confisca di prevenzione; la buona fede è collegata a diligenza e ragionevolezza
Non è possibile trarre automaticamente dalla situazione di crisi di un’azienda, o dalla manifestazione di un passivo della società richiedente un mutuo, l’inopportunità di concedere il credito da parte di una ...
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941